Radio Popolare Alternativa e altri spazi
Per tutti quelli che ancora oggi possono e sanno ascoltare ma soprattutto per
Luana
Canalini
Gianluca
Lerici
Enrico
Filippini
Marco
Ceretti
Tore Spanu
Giuliano
Fenelli
Betta
Nardini
Mi sono avvicinato alla politica verso la fine degli anni ’70, periodo in cui era ancora molto facile per un giovane trovarsi coinvolto in vicende e attività di carattere ideologico e sociale: e, quanto alla facilità del coinvolgimento, sarebbe stato l’ultimo, almeno fino ad oggi. Dopo le prime assemblee studentesche (il liceo scientifico Pacinotti, dove ho studiato, era assai vivace da questo punto di vista) iniziai a frequentare Piazza Verdi, allora ritrovo in settori distinti di molti giovani politicizzati sia di sinistra che di destra, e da qui, credo verso il ‘78 o '79, approdai a Radio popolare alternativa, una realtà avviata da diversi anni sul territorio dai compagni “più grandi”, ovvero della generazione che “aveva fatto il ‘68”. Io ero invece un ragazzino arrabbiato sopravvissuto per miracolo a un’esplosione da fuga di gas e conoscevo già benissimo, non retoricamente ma sulla mia pelle di grande ustionato, le arroganze del potere e di una sedicente giustizia sempre facile alla corruzione e ai pateracchi ai danni di chi è indifeso, come lo eravamo io e la mia famiglia, restati letteralmente solo coi vestiti che avevamo addosso dopo che l’incendio ci aveva distrutto la casa; e poi soli, indifesi dallo sciacallaggio che ci portò via (mentre erano “sotto sequestro giudiziario”…) le ultime suppellettili scampate al fuoco, soli e indifesi dinanzi alle posizioni di rilievo sociale e politico dei responsabili del disastro che dopo anni di pantomime giudiziarie e di marchiane irregolarità (segnalate senza esito al pessimo presidente della repubblica d’allora) riuscirono alla fine a non pagare le loro colpe, e il reato era quello, fra gli altri, di tentata strage. Avevo anch’io, insomma, la mia piccola strage senza giustizia e senza verità da rivendicare, anche se ben poca cosa, mi rendo conto, rispetto a quelle ben più cruente e dolorose che ha dovuto subire il nostro -in ciò- ben disgraziato paese, che ancor oggi sembra ignaro di quel che gli è successo. Rendo conto di questi fatti personali solo per sommi capi e per far intendere che la qualità della mia “rabbia” non veniva tanto da un immaginario allora ben attivo, quello appunto della cosiddetta hungry generation, quanto dall’avere precocemente assaggiato, appena quattordicenne e poi almeno per altri dodici anni, tanti quanto si protrasse la farraginosa vicenda giudiziaria, gli artigli subdoli e velenosi del potere. Chiaro che questa rabbia non indotta si nutriva di letture disparate, oscillanti fra «Umanità nova» e «Lotta continua», di qualche assaggio marxiano e la lettura di un paio di testi di Lenin che, pigliandosela coi menscevichi, ovvero mostrando tutte le meschine debolezze e gli accomodamenti del rinnegato Kautsky, mi convinsero a mia volta a detestare ogni soluzione riformista; si poneva però, allora e sempre, il problema di come fare la rivoluzione: come e con chi. Inutile sottolineare che l’idea della lotta armata serpeggiava e magari faceva presa sui più istintivi fra noi, senza tuttavia che si traducesse, almeno per quanto riguarda quelli della mia generazione, in pratiche o azioni conseguenti. Vivevamo per lo più in un alone di informazione, cultura e musica alternativa che ci tenevano aggiornati e compresi, certo con una buona dose di presunzione, riguardo al nostro ruolo di avanguardia. E poi, fra i pungoli che tenevano attivi i neuroni, c’era il cinema che allora in generale proponeva assai più facilmente di oggi cartelloni e programmi di eccezionale valore artistico, con la possibilità di accedere a vere opere d’arte che facevano divertire e pensare, ben lontane dai penosi menù multisala odierni monopolizzati dall’industria holliwoodiana: penso al mitico Arsenale di Pisa ma anche alle splendide iniziative spezzine di Enzo Ungari.
In
Radio naturalmente si faceva musica e la sigla d’apertura, quando arrivai io e
fino alla fine, era Stalingrado
degli Stormy six, un pezzo che non lasciava dubbi
sul fatto che a Radio popolare la musica si accompagnava sempre ad un discorso
politico che voleva o tentava di essere alternativo. Una radio diversa,
certamente unica nel panorama cittadino, che non faceva del semplice
intrattenimento: nella sede di via Lunigiana si tenevano animate assemblee, si
preparavano manifesti e volantini (nei primi tempi il ciclostile sfornava
questi ultimi in una particolare stampa azzurrina, poi fu sostituito dalla
fotocopiatrice), si pensavano e scrivevano tazebao e striscioni, si
progettavano attività politiche e culturali. Il nostro motto di quel tempo era
“Non sognare , fallo!” e fra le cose organizzate rammento
la mobilitazione per Bobby Sands, l’attivista nordirlandese
che fu fatto crepare in carcere dopo 66 giorni di sciopero della fame: prima
del tragico epilogo, raccogliemmo fondi e firme, chiamando a suonare al Palco
della musica un gruppo allora sconosciuto ai più ma destinato a diventare
celebre: Elio e le storie tese.
Ma dall’ambito della radio prese corpo anche l’occupazione dell’edificio dell’ex-collocamento
a fianco della Cattedrale,
atto clamoroso con cui tentavamo di ottenere spazi pubblici per i giovani in
una città che allora ne era totalmente priva; la cosa si risolse con 35 denunce
che per fortuna non ebbero poi alcun esito, così come del resto avvenne per la
richiesta di spazi, ovviamente disattesa dall’amministrazione comunale a guida
PCI, troppo presa da intrallazzi vari per occuparsi di noi e del problema
giovani (tanto per capirci, una delle nostre scritte dell’epoca recitava: “il
PCI di Spezia è come la DC di Palermo”). Da questa protesta nacque anche uno
spettacolo, anzi Spentacolo, titolo
che giocava sul nome della città storpiato in La Spenta: scritto e interpretato
da noi, vi collaborarono moltissimi amici (non io, troppo timido per il teatro)
fra cui ricordo almeno Betta Nardini, Roberto
Alinghieri - che poi sarebbe diventato quell’ottimo attore
che è oggi- e Mario Bucceri; l’evento era divertentissimo ed ebbe molto
successo, tanto che dopo la prima -mi pare all’Unione Fraterna - il Comune della
Spezia (erano i tempi del buon Antonello
Pischedda) dette addirittura il permesso di replicarlo
al Civico. La creatività era del resto una caratteristica del movimento e fra
piazza Verdi e la radio nacque un gruppo (non)musicale specialissimo, composto
da non musicisti, cioè da tutti quelli fra noi che pur possedendo e
strimpellando uno strumento, non potevano certo dire di possedere ogni segreto del
pentagramma. Il gruppo, su mia istigazione (mi è sempre piaciuto trovare nomi e
titoli), si chiamava Le Armi Turche e
prevedeva la seguente formazione: Gp al clarinetto, io al sax alto, Findus
all’armonia e chitarra, il Barba alle percussioni, il Folle voce solista (uso
di proposito i soprannomi, non vorrei che qualcuno si risentisse… in tutti i
sensi). Nostro scopo precipuo era quello di fare da incursori e guastafeste
durante le manifestazioni musicali organizzate dal PCI e dal comune; come tutti
i timidi e imbranati, io avevo le mie punte di spavalderia e le sfoderai insieme
agli altri producendo con incredibile faccia tosta in pubblico un coacervo di
suoni e rumori che, diciamo così, andavano ben oltre il free jazz. Ciò avvenne
in almeno due occasioni, al Centro
Allende e durante una festa dell’Unità: inutile dire
che dopo uno o due pezzi, appena la curiosità si mutava in fastidio, il
figiciotto che incautamente ci aveva permesso di salire sul palco si incaricava
di farci smettere anche con non velate minacce, dando seguito alle irose
proteste della quasi totalità del pubblico: notammo in effetti con un certo stupore,
fra gli insulti e gli improperi piuttosto meritati al nostro indirizzo, che
qualcuno oltre a noi riuscìva pure a divertirsi.
In
radio non si trasmetteva soltanto, ma si faceva musica (ci furono anche
concerti live, ne ricordo bene almeno uno dei Fall out) e si produceva, perché no, cultura: c’era gente che
passava il tempo in radio anche scrivendo poesie o disegnando: così ad esempio
la tessera della radio, che mostrava un sorridente faccione di Frankenstein,
era stata ideata da Gianluca Lerici; fra i frequentatori assidui c’erano anche
due ragazze cilene, Assunta e Zorkunde, e un italo-brasiliano nativo di Porto
Alegre, Marco Ceretti detto il Barba che ci facevano conoscere la cultura
musicale della loro gente, ben prima che esplodesse la moda della world music.
Io ero interessato al discorso politico, tenevo programmi di jazz e musica dal
mondo (detesto per quest’ultima la limitativa definizione di ‘etnica’), intervenivo
di rado nelle assemblee, e ciò per problemi miei di poca spigliatezza, ma più
spesso scrivevo testi di volantini e tazebao. Uno di questi testi fu trovato in
bozza, durante una perquisizione personale per strada (caso allora molto
frequente) alla mia fidanzata dell’epoca, Roberta, che per questo subì una
perquisizione notturna in casa, senza peraltro rivelare, con una piccola ma per
me molto opportuna dose di eroismo, chi fosse l’autore di quella mezza
paginetta che si scagliava contro la magistratura asservita al potere e dunque implacabile
nel perseguitare i compagni. Un’altra volta accadde che alcuni compagni,
giovani studenti come me, tornarono piuttosto abbacchiati da un volantinaggio
dinanzi ai cantieri INMA: gli operai del PCI li avevano malmenati e duramente
apostrofati con una delle frasi che allora ricorrevano frequentemente in simili
casi: “Ah tu sei studente? Cosa vuoi? Sono io che lavoro e io che ti mantengo!”.
A cui rispondevo, quando mi capitava di ricevere personalmente la diffusa e arrogante
obiezione, che non si disturbassero, visto che mio padre era operaio come loro
e mia madre casalinga (dalle mani d’oro, che si dava da fare con mille lavori
di uncinetto, ricamo e sartoria) e dunque erano loro a mantenermi agli studi
senza alcun bisogno del concorso altrui.
Fra
gli episodi più gustosi ricordo invece un attacchinaggio di manifesti per la
libertà di un compagno di Santo Stefano arrestato, ci avevano detto, col
pretesto di un ritrovamento di pochi proiettili arrugginiti. I manifesti erano
vistosi, con un grande gabbiano in volo, chiaro simbolo della libertà che
chiedevamo per il compagno secondo noi ingiustamente arrestato. Partiti in tre
di buona voglia, avevamo già tappezzato parecchi muri di Mazzetta con sicura
baldanza, non disdegnando neppure la sede dei carabinieri di via Ugo Foscolo
dove con l’incoscienza di chi crede di agire per una causa giusta ne avevamo
incollato uno proprio sotto la targa, all’ingresso della caserma. Proseguimmo
imperterriti con l’ultimo manifesto da attaccare fino all’angolo di via Foscolo
e qui, non sapendo dove piazzarlo, lo appiccicammo con inutile spavalderia per
terra, sul marciapiede. In quella sopraggiunge ahinoi un’auto di carabinieri
che inevitabilmente ci nota, ci ferma, ci chiede i documenti e ci invita a
seguirli nella vicina caserma…. Già, in caserma… dove, appena arrivati i militi
non possono fare a meno di notare il grosso manifesto ancora gocciolante di
colla attaccato appena sotto la targa…. dire che eravamo più impauriti che
imbarazzati non rende l’idea, ci spedirono subito fra commenti ironici dal
maresciallo che per nostra fortuna era un buon uomo, io che ero notoriamente
piuttosto imbranato in quella occasione tirai fuori una parlantina da disperato
e sbrodolai un discorso sul fatto che avevano attaccato quel manifesto perché
volevamo che anche i ragazzi della caserma sapessero dell’ingiusto arresto, che
era stato un atto di democratica controinformazione che intendeva coinvolgere e
non offendere le forze dell’ordine. Come che sia, ci lasciarono andare senza
nemmeno denunciarci: il maresciallo aveva ben valutato l’accaduto con
encomiabile buon senso (lo stesso che all’epoca disprezzavo a priori) e quale
poteva essere la nostra reale pericolosità sociale.
Un
altro manifesto, ma qui -malgrado ci fosse di mezzo la radio- la politica
c’entrava ben poco, mi costò un pestaggio tale da mandarmi in ospedale. La spiacevolissima
disavventura andò così: eravamo in tre, tranquillamente seduti a berci una
birra da Morlando (dietro piazza Brin, che -tengo a precisare- grazie agli
autoctoni era un posto poco raccomandabile ben prima dell’arrivo degli
extracomunitari: e francamente, visto un simile genius loci, non capisco di cosa ci si lamenti oggi) quando si
presentarono due tipi mai visti prima che senza mezzi termini ci chiesero se
eravamo di Radio popolare, alla mia risposta affermativa ci dissero di uscire
un attimo fuori per parlarci. Non conoscendoli rifiutammo, anche perché
l’invito a venir fuori da un locale in certi contesti ha sempre avuto un chiaro
significato rissaiolo. Fatto sta che, finita la birra, uscimmo e trovammo i due
molto torvi in viso che ci aspettavano: finalmente capimmo cosa volevano, ci
dissero che un tizio di Radio popolare
alternativa era entrato nella vicina sede di Radio Spezia Sound chiedendo di attaccare un manifesto e a dir loro
spaventando coi lori modi spicciativi un ragazzo cardiopatico. Naturalmente
dicemmo, ed era vero, che non sapevamo chi aveva compiuto quell’atto e comunque
ci scusammo per l’accaduto: ma evidentemente non erano le scuse quelle che i
due erano venuti a cercare da noi. Di fare a botte con sconosciuti per qualcosa
di cui non sapevamo nulla non avevamo la benché minima voglia e così, malgrado
la nostra superiorità numerica, al primo gesto aggressivo, un fulmineo tentativo
di slerfon, ce la svignammo di corsa
prendendo tre direzioni diverse… ero da
solo quando, circa una mezz’oretta dopo, mi ritrovai faccia a faccia con i due
tipacci in piazza Garibaldi, proprio sotto al negozio di Panattoni. Non
riuscìii nemmeno ad aprire bocca, figuriamoci ad agire, il più alto e il più
stronzo dei due si girò su se stesso e mi affibbiò un calcio in faccia in puro
stile karateka (in quegli anni andavano molto i film di Bruce Lee, ed era
tutt’altro che raro trovare in strada imbecilli giovani e meno giovani che
provavano a imitarne le gesta). Quella è stata l’unica volta in cui sono
svenuto in vita mia: mi ricordo soltanto che mi sono ritrovato non so come in
piazza del Mercato, verso le tre di notte, aggrappato a una delle fontanelle mentre
mi sciacquavo la bocca insanguinata assistito da Parietti, celebre tossico
mezzo matto del tempo, che però in quella occasione mi fece da provvidenziale
infermiere: “Cosa ti è successo?” “Mi hanno tombato… due di piazza Brin”, “Devi
andare al pronto soccorso, hai il labbro spaccato di brutto”… e in effetti,
toccandomi, sentivo un’apertura anomala sul labbro superiore. In ospedale non
denunciai i tipi che mi avevano aggredito (a parte il fatto che non ne
conoscevo il nome, la cosa non si usava allora, se qualcuno ti aggrediva
cercavi di rendergli pan per focaccia tenendone fuori le forze dell’ordine), mi
misero diversi punti al labbro e vennero a trovarmi in molti, fra cui GP e
Giuliano Fenelli che avevano provato a vendicarmi ma erano finiti bussati anche
loro; miglior sorte ebbe il tentativo di Panelli, nerboruto batterista dei Nuts, che riuscì invece a farsi
rispettare e la cosa finì lì, senza ulteriori faide. Dopo qualche tempo
incontrai sul treno per Pisa uno dei due, G., che mi chiese scusa: era il meno stronzo
dei due, che a quanto potevo ricordare non mi aveva colpito e accettai le sue
scuse: io andavo per l’Università, lui per la visita militare e facemmo il
viaggio insieme… era un povero diavolo, tossico come l’altro, e fui
sinceramente dispiaciuto quando seppi, qualche tempo dopo, che si era ammazzato
in carcere dov’era finito per problemi di droga.
Ora
basta con gli aneddoti, però: mi tocca raccontare del periodo buio in cui la
radio purtroppo dovette chiudere. Dopo i
compagni che l’avevano fondata, anche i cosiddetti autonomi che avevano preso
il loro posto a poco a poco se ne andarono: si era ormai negli anni del famoso
“riflusso” e c’erano state discussioni per via della, diciamo così, scarsa
democrazia all’interno della radio, il gruppo di autonomi partecipava alle
assemblee ma del parere altrui se ne fregavano altamente, le decisioni su come
muoversi e sull’indirizzo della radio venivano prese in riunioni che si tenevano
a casa loro. Per reagire a questo stato di cose scrissi un tazebao per il quale
si sfiorò la rissa: avevo osato usare la parola “fascismo” a proposito di
simili comportamenti cosicché uno dei superortodossi incontraddicibili tentò di
mettermi le mani addosso in piazza Verdi, ma fortunatamente ci separarono
subito. Per quanto ne avessimo criticato spesso metodi e contenuti, tuttavia il
vuoto politico lasciato dai compagni più grandi si fece sentire eccome: ci fu
un breve periodo in cui la radio divenne ritrovo dei punks e di persone (come
il punk Piombino, la trans Valentina) che occasionalmente si trovavano senza un
luogo in cui dormire. Fra i punks c’erano persone intelligenti e amiche (come
il già menzionato Gianluca Lerici, il Doctor Trip troppo presto finito fra i
più) e altre che seguivano esclusivamente la moda, alcune degenerando anche,
duole dirlo, nel deprecabile fenomeno neonazi degli skin heads: ma sempre e
solo per seguire la moda, senza vere ricadute politiche. Fu questo il periodo
in cui noi che eravamo poco più che ragazzini tenemmo le redini della radio
cercando di mantenerle un indirizzo preciso sia dal punto di vista
politico-culturale che da quello amministrativo: fui nominato economo senza
averne alcun titolo (e fui l’ultimo, conservo ancora qualche bolletta pagata) e
posso dire di aver seguito la radio quando ormai era stata abbandonata da tutti
o quasi, fino all’ultimo giorno: una bolletta della luce di poche migliaia di
lire non onorata ne sancì la fine. Ma l’agonia fu qualcosa di tragicomico:
ormai era saltata ogni benché minima idea di palinsesto e di programmi, chi
arrivava in radio apriva le trasmissioni a qualsiasi ora e iniziava a
trasmettere quel che più gli piaceva, senza alcun tipo di freno o (se ce n’era
mai stato) di controllo. Un giorno uno dei nostri amici postaleros (così erano chiamati i frequentatori di piazza Verdi)
aprì il microfono e profittando di una batteria lasciata lì dopo un concerto
iniziò a tamburellare una sua scontata cadenza, intonando al tempo stesso
quello che dottamente si potrebbe anche definire un inno a Baubo,
ma che nella trita realtà era un osceno e volgare ripetere senza posa sempre la
stessa frase, che poi consisteva unicamente nell’encomio senza mezzi termini
del genitale femminile. L’amico era certamente su di giri ma non rimase l’unico
a prodursi in simili performances,
tanto che alcuni barbieri della città, per la soddisfazione propria e dei loro
clienti, si erano ormai abituati a sintonizzarsi sulla radio, perché davvero
poteva capitare di sentire sproloqui, frizzi e boutade, ma anche appunto veri e propri deliri che altrove ci si
guardava bene dal mandare via etere e ciò naturalmente suscitava ilarità negli
ascoltatori. Infine, la radio chiuse, ma ancora sopravvisse in qualche modo nei
primi anni ’80, e sia pur brevemente, nel bell’edificio delle scuole del
Vignale, sotto il nome di Radio Hapax;
il nome glie lo avevo dato io ma non lo capì nessuno nel suo senso analogico
(preso dal gergo letterario) di cosa unica, irripetibile, c’era anzi chi senza
volerlo lo storpiava in Radio Apache.
Pochi volenterosi compagni avevano rimesso in piedi l’occorrente per
trasmettere e io continuai a trasmettere sia un programma di jazz che uno di
musica dal mondo. Ben presto, però, la situazione si rivelò ancora più difficile
di quella che avevamo lasciato in via Lunigiana: i punks presero a bivaccare e
a dormire in massa nei locali del grande edificio, e al posto dei compagni ormai
rarissimi vennero a trasmettere anche alcuni fighetti spezzini che nulla
avevano a che fare con le nostre storie e le nostre idee. Un giorno ne sorpresi
alcuni che mandavano i Bee gees e mi
girarono veramente a frullatore: pur nella decadenza, la diversità era sempre
stata un carattere imprescindibile anche della nuova radio, affissi allora in
sala trasmissioni un foglio che spiegava il significato del termine Hapax e che
invitava i fighetti ad andare altrove a trasmettere i pezzi che tutte le altre
radio trasmettevano in fotocopia, ossequienti alle logiche mercantili delle majors. Ormai la radio non faceva più
politica, i temi del conflitto sociale si affrontavano ormai quasi solo sotto
l’aspetto musicale e, cosa che fa molto comodo al potere, la ribellione era
ormai diventata un mero fatto di costume, per non dire proprio una moda. I
punks si erano ormai domiciliati nell’edificio del Vignale e, forti della
presenza costante, inzeppavano il palinsesto della loro musica, guardando in
cagnesco i pochi che ancora si ostinavano a non assimilarsi. Tenni ancora
qualche trasmissione di jazz e musica dal mondo, togliendomi una volta la
soddisfazione, poiché la musica trasmessa veniva amplificata per tutta la sede,
di sorprendere i punks che ballavano come matti sul ritmo indiavolato di Hasapiko sirto degli Zsaratnok
che stavo trasmettendo. Dopo qualche mese di trasmissione, anche Radio Hapax chiuse miseramente i
battenti; io mi misi a studiare sodo per recuperare il primo anno d’università
andato praticamente perso, a poco a poco ci perdemmo di vista con i compagni e il
passaggio dal pubblico al privato di cui
tanto si parlava si rivelò tutt’altro che indolore: molti caddero nella
trappola dell’eroina e qualcuno si fece suggestionare dalla lotta armata: con sorpresa
e dolore poi avremmo saputo che uno degli autonomi (anche simpatico) che
frequentava la radio si era affiliato alle Brigate rosse. Ma tutto intorno a
noi era ormai cambiato dopo l’omicidio Moro,
evidentemente teso a impedire -lo capiamo bene oggi- una riconciliazione nazionale
invisa ai nostri padroni d’oltreoceano che riuscirono a piegare la lotta armata
(e in generale il terrorismo sia di destra che di sinistra) ai loro biechi interessi;
quello che da molti fu creduto e scambiato per un atto rivoluzionario era in
realtà una ben precisa mossa al servizio delle peggiori forme di potere,
nazionali e internazionali. Eravamo ormai ben addentro ai ‘favolosi’ anni ’80 e
la gente iniziò a richiudersi in casa per dedicarsi al proprio ‘privato’, poi
arrivarono i computers e i video-games a consolidare la tendenza: comparvero le
t-shirt con loghi e scritte spesso insensate, privando di senso anche quelle
che in passato lo avrebbero avuto (la celebre maglietta del Che, ad esempio),
la gente cominciò a sentirsi soddisfatta indossando ed esibendo le firme degli
stilisti sui propri indumenti, la superficialità e la comodità anche ideologica
e morale presero piede in ogni campo e il profitto cessò di essere demonizzato:
in breve, si concludeva, ormai senza più opposizioni né speranze, il genocidio
antropologico e culturale preconizzato da Pier Paolo
Pasolini.






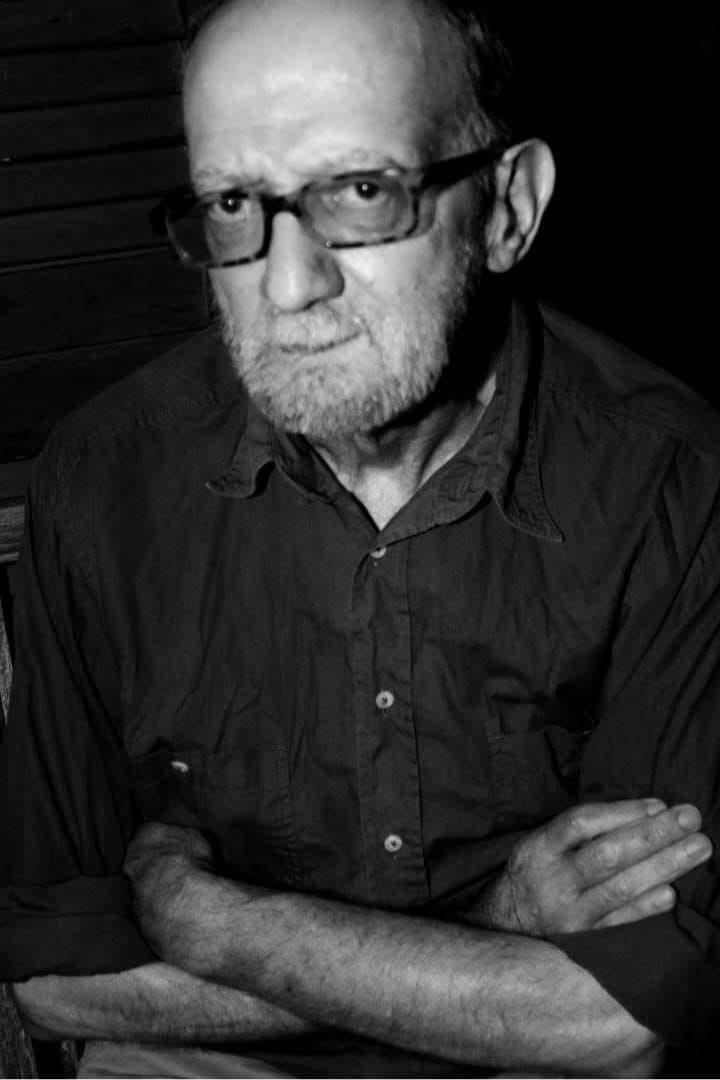
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiElimina