C’era una volta in Palmaria
Parafrasando due titoli di film di Sergio Leone, penso che questo mio racconto potrebbe essere il canovaccio per una sceneggiatura di un film del tipo di C’era una volta il West oppure di C’era una volta in America. Ci sono l’avventura giovanile e un ambiente che è già cambiato, dagli ultimi anni Sessanta nei quali, d’estate, mia mamma a volte ci portava sino alla spiaggia della Batteria Carlo Alberto. Piazzava un ombrellone leggero tra le pietre della spiaggia di sassi, s’infilava un buffo cappello di paglia che a quel tempo doveva parere elegante, indossava il suo monopezzo a disegni colorati e le scarpine di gomma per non pungersi con i ricci di mare (allora ce n’erano molti). A me e a mio fratello Claudio dava le maschere e i boccagli per fare quello che molto più tardi fu chiamato “snorkeling” ma che mia mamma maestra chiamava “osservare il fondo”. C’erano cose interessanti, oltre alle praterie di Posidonia, e noi catturavamo con un retino, senza nessuna educazione ecologista, granchi vivi con cui giocavamo mettendoli nel secchiello di mio fratello, portato apposta per quello scopo, non essendoci sabbia con cui giocare nella spiaggia. Ci passavamo ore, così, e la mamma ci richiamava insegnandoci che quando notavamo le dita aggrinzite e molto pallide dovevamo uscire dall’acqua perché non ci faceva bene restarci troppo a lungo. Avevamo però i nostri giornalini e le carte da gioco, con le quali giocavamo con la mamma a rubamazzetto, il gioco più semplice che il mio piccolo fratellino potesse capire. Per giocare con noi, mia mamma lasciava da parte la sua rivista femminile, che poteva essere OGGI, GRAZIA, ANNA, Annabella, Confidenze o piuttosto Intimità, che era quella che lei preferiva. Era ricca di racconti e articoli per lei interessanti e ne ricavava idee di moda o per lavoretti femminili come l’uncinetto o il ricamo e ricette di cucina sempre nuove di cui noi apprezzavamo la varietà. Pranzavamo sotto l’ombrellone con l’insalata di riso, per noi solo un piatto estivo, e panini con il prosciutto cotto o crudo. Con la pesca ci sporcavamo tutti ma ci tuffavamo in mare con la raccomandazione della mamma di uscirne subito perché secondo lei dopo mangiato si devono lasciar passare almeno due ore prima di potersi di nuovo bagnare. Quelle due ore, che, da un corso di sicurezza per i bimbi dedicato a genitori e nonni che ho frequentato ieri, ho imparato essere una credenza solo italiana del tutto errata, erano pesanti e molto noiose, lì sotto l’ombrellone in tre. Per sfuggire alla noia cercavamo di fare amicizia con altri bambini o bambine che pure loro erano al Carlo Alberto. Poiché la mamma ci portava raramente alla Palmaria e preferiva il mare della Baia Blu o di San Terenzo, che le permetteva di risparmiare il biglietto del vaporetto e della corsa sino alla destinazione finale, poiché prendevamo il filobus numero “2”, da tempo soppresso, che ci portava sino al Muggiano, che ne era il capolinea, e c’incamminavamo a piedi sotto la Galleria degli Scoglietti o sulla strada che sale a Pozzuolo e scende sino alla Baia Blu. Questa era una bella scarpinata ma presto mia mamma, che non era spezzina ma lombarda dell’Oltrepò pavese, imparò una scalinata che parte a fianco dell’imbocco della galleria ed evita la lunga salita di Pozzuolo. Io avevo un po’ paura della Baia Blu, non solo perché per raggiungerla a piedi per risparmiare quei pochi spiccioli dovevamo camminare molto anche su sentieri brulli o contornati dalla vegetazione, che era l’unico modo di non passare da strade private e accedere alla spiaggia libera senza sottostare al pedaggio dello stabilimento balneare a pagamento. C’era la ragione dell’altro nome, la Baia dei morti, che mi faceva fortemente temere di vedermene spuntare uno accanto mentre facevo le mie corte nuotate dove l’acqua era bassa. Mio papà mi aveva raccontato che un gioco di correnti, se qualcuno fosse annegato in mare, ne avrebbe portato lì i corpi. Da qui il nome macabro. A San Terenzo andavamo più volentieri, anche se la galleria che dovevamo attraversare a piedi era buia, umida, e correvamo il rischio di essere travolti dalle auto, dagli autobus e dagli altri veicoli che sopraggiungevano dalle nostre spalle. Il transito a piedi è vietato già da moltissimi anni. A San Terenzo era più facile farsi degli amici nuovi e c’erano i magici venditori di cocco, con le loro grida “Cocco bello!” che conquistavano la mamma che ce ne comprava due pezzi. Pure lei ne era golosa. Quando nacque nostro cugino Enrico suo papà e mia zia Renata affittavano una casa in paese e perciò andavamo sempre lì.
La Palmaria ci mancò per diversi anni, almeno sino a quando io diventai indipendente e avevo un amico che era figlio di un arsenalotto. La sua famiglia pagava una quota con una trattenuta sulla paga per avere il privilegio di accedere, trasportati dalla motonave “Betta”, allo stabilimento del Dopolavoro Dipendenti Marina (D.D.M.). Il mio amico Massimo mi volle suo ospite fisso e talvolta, qualche domenica, vennero pure mio papà, la mamma e Claudio, ospiti anche a pranzo. Lo stabilimento aveva tutte le comodità, c’era l’ombra, nelle zone per consumare privatamente i pasti, c’era la mensa, che preparava buoni piatti a prezzi veramente bassi, c’erano un’area giochi, i calciobalilla, tavolini per giocare a carte, a dama e a scacchi, ombrelloni ben fissati in piedistalli di cemento, il pontile di attracco della Betta da cui ci tuffavamo e un pontone galleggiante ancorato sul fondo, ben attrezzato con un trampolino per i tuffi, che era fissato su una struttura in legno rivestita di tela, dalla quale ci lanciavamo a conchetta per schizzare le ragazze. Ho imparato lì a tuffarmi di testa con tuffo carpiato e pure ad esibirmi in un quasi perfetto tuffo ad angelo. In questo, Massimo mi superava. Quando, un agosto, decidemmo di fermarci nell’isola per un campeggio, noi aspettammo che, lentamente, tutti gli ospiti s’imbarcassero sulla “Betta”, che segnalò con due colpi della sua sirena la partenza. Tutti gli sguardi dei nostri amici che rientravano a casa erano rivolti al trampolino su cui noi prendevamo gli ultimi raggi del tramonto e Massimo fece due passi sull’asse del trampolino, facendola vibrare in un sobbalzo e, a piedi uniti e distesi, eseguì un tuffo ad angelo perfetto. Gli fecero l’applauso e forse lo fecero pure a me che l’imitai subito, con discreto successo. Provammo un intenso senso di libertà, con tutta l’isola a nostra disposizione, da condividere con i nostri compagni di tenda, all’interno di un giardino privato che ci aveva concesso di pernottare lì, con una chitarra, l’amico Marco Rivieri e un altro paio di ragazzi dei quali ho perso la memoria. Ci preparammo la cena su un fornelletto a gas da campeggio, un piatto di spaghetti con il sugo di un barattolo di vetro che era stato preparato forse dalla nonna di Massimo, cuoca esperta di cui apprezzavo le specialità. Mi ricordo esattamente una sola canzone di quella notte, passata ad impararla. Era “Amore dove sei” di un cantautore che mi è rimasto sconosciuto per sempre, sino ad ora che ne ho ricercato le poche parole che ancora ricordo, parole che si ripetono spesso: “Come sassi noi siamo, inerti e inamovibili… “. Si chiamava Giorgio Laneve. Leggendone ora la biografia, m’immagino che l’anno del campeggio fosse il 1970, cioè l’anno in cui con quella canzone lui partecipò a Un disco per l’estate.
Concludemmo la nostra serata con un gelato sulla terrazza del ristorante che ora è la Locanda Lorena ma che era allora di proprietà di uno storico abitante della Palmaria, Sergio, che gestiva il ristorante, il bar, le camere, si muoveva tra la Palmaria e Portovenere con il suo motoscafo. Era amico di Sandro Pertini, che pure quando fu Presidente della Repubblica e ricapitò a Spezia, lo andò a trovare passando insieme con lui delle ore. Noi, su quella terrazza, restammo in silenzio ad ammirare le luci di Portovenere con le nostre coppette vuote in mano.
Il giorno seguente mi svegliò un gallo molto presto. Io mi misi a riordinare l’esterno della tenda dove giacevano asciugamani zuppi di umidità e li stesi ad asciugare su una corda legata a due bassi alberelli di ulivo. Poiché tutti dormivano, e lo stabilimento era chiuso, andai a tuffarmi dal cubo di cemento della Batteria Carlo Alberto, un tuffo che nessuno vide. Rimasi un po’ lì e poi tornai sui miei passi sino al giardino dov’era la tenda ma, vedendo che nessuno si era ancora svegliato, raccolsi una decina di pietre piatte e mi sedetti su un pontile basso sull’acqua per farle rimbalzare. Ero bravo a fargli fare molti salti in successione ed anche a fargli fare salti alti e non mi accorsi che sopraggiungeva uno con un barchino a motore. Il sasso gli passò sopra, miracolosamente. Lo stupore di un incidente evitato mi rimase impresso per molto tempo e, ora, me ne è tornata alla mente la meraviglia. Devo ringraziare il caso di non aver fatto male a nessuno e di non avere colpito neppure la barca.
Allora scaldai un po’ d’acqua e feci un tè con una bustina della nonna di Massimo. Avevamo pure lo zucchero e qualche biscotto. Gli altri mi raggiunsero e avevano proprio l’aspetto di quelli che “La sera leoni, la mattina… “. Ma poi, subito dopo quei biscotti, si tuffarono in mare lì davanti, tra le barche.
Arrivava la “Betta” con il suo primo carico di bagnanti mattinieri e il Bagno del D.D.M. aprì mentre noi eravamo già sdraiati sulle sdraio ad asciugarci al sole essendoci entrati dal mare a nuoto. Le ragazze che la sera prima ci avevano visto tuffarci ad angelo ci attorniammo e raccogliemmo il nostro momento di gloria, flirtando un po’ con una e un po’ con un’altra, e poi le sfidammo a raggiungerci sul trampolino per iniziare i tuffi di quell’altra splendida giornata di sole. Un paio di loro dissero che avevano fatto colazione da meno di due ore, perché eravamo un po’ tutti vittime di quella credenza. Solo noi ribelli la sfidavamo, se non erano presenti ‘i grandi’. Avevamo infranto questa ‘legge’ e non eravamo stati male, la congestione non ci era venuta e, perciò, l’esperienza aveva messo in dubbio la legge.
Il nostro piano per la mattinata era di portarci qualche ragazza a fare i tuffi dalla piattaforma del trampolino e poi di invitarle a fare una camminata fuori dallo stabilimento in direzione del forte davanti a Torre Scola. Qualcosa sarebbe potuto accadere. Il piano riuscì a metà perché furono poche quelle che ebbero il permesso degli adulti ed eravamo in sovrannumero, noi maschi. Andammo sino alla spiaggia tra Torre Scola e il Pozzale, io tallonavo con le mie chiacchiere quella che mi piaceva e che nella spiaggia mi si sdraiò vicino, ma, come di prammatica, non arrivai a nulla. Fu un insuccesso pure per gli altri. Rientrammo in tempo per mangiare nell’ultimo turno della mensa e poi giocammo a Scala 40 all’ombra, su un tavolino a sei, con due ragazze che ci guardavano le carte da dietro le spalle. Se mi sfioravano, provavo un brivido e scartavo una carta ‘messa’. Dicevo che stavo pensando ad altro e lei capiva…
Giocavamo, ci esercitavamo come a grandi manovre inconcludenti, sparavamo a salve.
Altri tuffi, le nostre energie erano inesauribili, altra partenza dell’ultima “Betta”, Klaus Di Biasi riandò in scena, ancora una volta prima di me, applausi per entrambi. Dopo un po’ di sole sul trampolino, ci venne la malinconia. Era solo il secondo giorno di campeggio e l’indomani sarebbe stata la domenica e il nostro campeggino finiva. Ci comprammo dei panini sostanziosi da Sergio per cena e trovammo uno che viveva alla Palmaria che aveva un gozzetto. Ci mettemmo d’accordo che ci avrebbe portato la sera a Portovenere, se remavamo noi. Armandino era un ragazzo obeso di una simpatia unica e remavamo volentieri perché ci raccontò delle storielle su alcuni ‘soggetti’ di Portovenere che noi non conoscevamo che avevano fatto delle cose veramente assurde. Ci sarebbe stato da aspettarsi di tutto pure da lui, immaginavamo. Ci seguì un altro barchino di un suo amico allampanato con la barba, più grande di noi, che ne portò altri due. Però voleva remare sempre lui, sulla sua barca. Armandino, invece, seduto a prua, si occupava della nostra allegria. Eravamo già su di giri per i suoi racconti, sbarcammo al molo e legammo i gozzi e ci mettemmo a passeggiare verso San Pietro, ma svoltammo indietro perché notammo una ragazza bellissima con i capelli molto lunghi e la seguimmo, solo per guardarla, senza nessuna intenzione. Non dicemmo una parola neppure tra noi. Pura adorazione. Lei s’impaurì, vedendosi seguita, e si rifugiò nel bar dopo il distributore di benzina. Parlottò con la cassiera. Anche noi entrammo e ci sedemmo. La cassiera-cameriera venne a prenderci l’ordine, mentre quella ragazza ci guardava. Curiosamente, ordinammo tutti bevande al latte, chi latte naturale, chi un latte e menta o un latte e amarena. La cassiera fece un segno alla ragazza che se ne poteva andare, perché noi saremmo rimasti a consumare ciò che avevamo ordinato. Quando la cameriera fece tintinnare i bicchieri di latte sul vassoio, Armandino le muggì contro: “Muuuhh!” e noi e lei scoppiammo a ridere.
La nottata, in mare, era magnifica, con le luci di Portovenere alle spalle, qualche raro lampione acceso della Palmaria completamente buia e tutte le stelle che ci sovrastavano. Approdati al Terrizzo, restammo a chiacchierare seduti sul bordo del molo, poi ci salutammo come in un addio. Quella notte rimasi con la testa fuori dalla tenda ad ammirare le stelle, con il corpo nel sacco a pelo. Quando i pensieri si placarono, rientrai e mi addormentai subito.
La domenica smontammo la tenda e la portammo allo stabilimento, per riportarla al proprietario che ce l’aveva prestata, quando saremmo ripartiti con la “Betta”. Fu una domenica al mare come tante altre, ciascuno se ne andò con orari diversi. Quando la “Betta” suonò la sirena e ripartì verso Spezia, sulla piattaforma del trampolino non c’era nessuno.



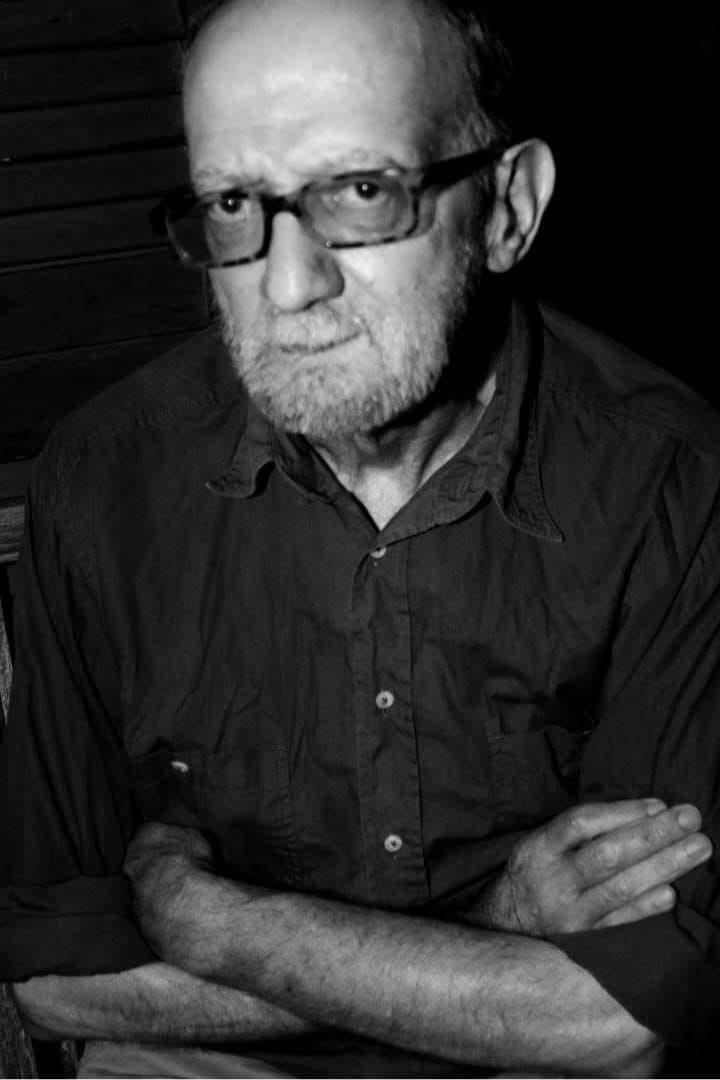
Commenti
Posta un commento