L’ALTRA RESISTENZA: GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI NEI LAGER NAZIFASCISTI
Mio padre Pietro era nato nel 1921. Mi raccontava che per lui -
bambino, adolescente e giovane uomo - il fascismo, "cresciuto" negli
stessi anni, era la normalità.
Ricordava che da ragazzino, a La Spezia, era un commesso in un negozio
di abbigliamento, dove indossava il classico camice nero da lavoro: qualche
volta, quando il regime chiamava alle adunate nelle piazze, per fare prima
infilava il camice nei pantaloni, trasformandolo in una camicia nera.
Le leggi razziali fasciste non lo colpirono troppo, anche perché a
Spezia c'erano pochissimi italiani ebrei. E sembrava quasi vero - a un giovane
di allora - che l'Italia fosse una grande potenza con una "purezza"
da proteggere. Poi venne la guerra: lui e i suoi coetanei erano ventenni quando
scoppiò. Finirono tutti "abili e arruolati" e in gran parte non
tornarono.
Quando le armi tacquero, raccontava, cercò gli amici, gli ex compagni
di scuola, e non ritrovò quasi nessuno. Nel frattempo era stato prigioniero,
con il fratello gemello Paolo, per quasi due anni in Germania, come Imi (internato militare
italiano): uno dei tanti ex soldati che preferirono i lager all'arruolamento
nell'esercito della Repubblica sociale di Mussolini.
La realtà - dopo che la propaganda nazifascista era stata spianata da
morti, sofferenze, fame e distruzioni - appariva un incubo. Anche perché ogni
ora trascorsa nel campo di concentramento poteva essere l'ultima.
Un giorno, in Germania, vicino a Lipsia, scoprì anche qual era stato il
risultato delle leggi razziali: in mezzo alla neve, di ritorno nel suo campo
dopo i lavori forzati, vide una colonna di uomini e donne macilenti e coperti
di stracci, spinti da soldati tedeschi; chi rallentava o cadeva veniva ucciso e
buttato sul cassone di un camion. Erano ebrei e altri candidati (rom, omosessuali, prigionieri
politici, eccetera: 15 milioni in tutto le vittime) alla "soluzione
finale", cui il fascismo stava collaborando.
Quando me lo raccontava, anche negli ultimi anni della sua vita (se ne
è andato a 83 anni nel 2004), non riusciva a non piangere. Io me lo ricordo. E
lo ricorderò a suo nipote Pietro (nato quasi un secolo dopo il nonno) che lo
ricorderà, spero, ai suoi figli, un giorno.
- Perché la memoria è un
dovere e anche un dono; tanto più in quest'epoca in cui divisioni, muri,
paure propinate con premeditazione, nazionalismi e razzismi stanno
diventando ancora gli slogan di leader politici senza scrupoli.



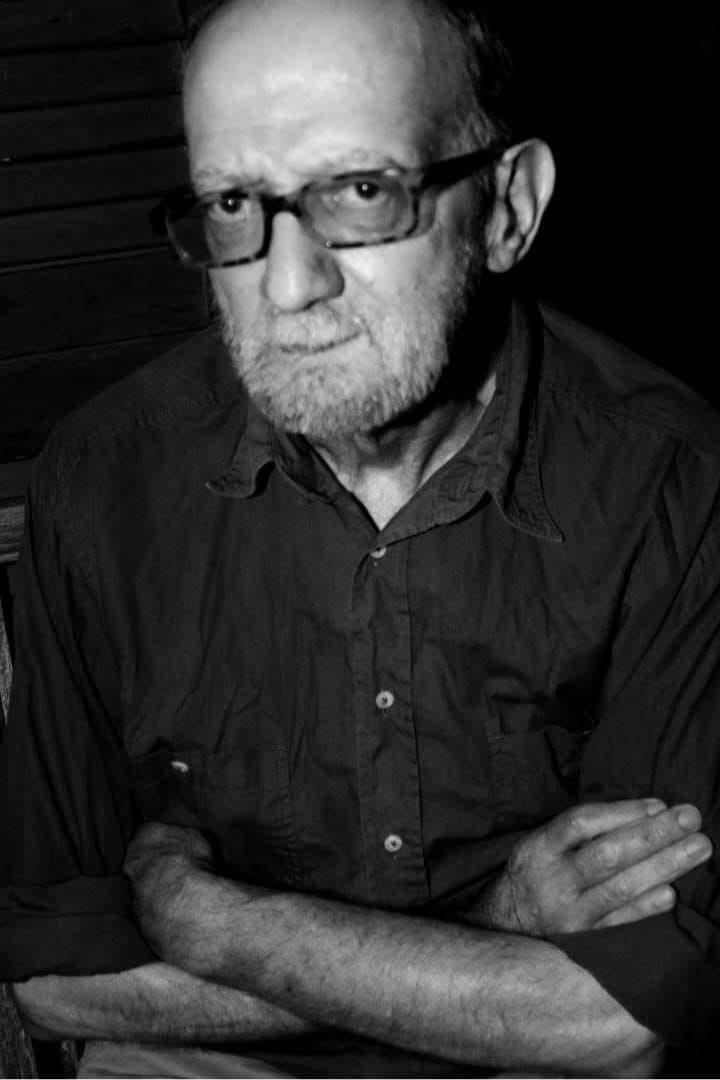
Commenti
Posta un commento